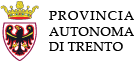Vita ad alta quota sulla Cordillera Blanca
Sulla Cordillera Blanca sembra di essere su un altro pianeta. Ã come se improvvisamente dal cielo piccoli cubi colorati fossero caduti disponendosi in ordine sparso, senza un senso apparente, su una crosta dura, arida e rocciosa. Viaggio alla scoperta dei 30 anni di cooperazione allo sviluppo nella regione andina dell'Ancash.
di Cristina Dalla Torre, Camilla Forti, Daniele Saguto, Chiara Zanotelli
Sono solo quattro i giorni passati sulla Cordillera Blanca, nella regione di Ancash, lontani dai ritmi frenetici della città e dalle nostre comode sicurezze. Pochi, è vero, però quanto basta per farci cambiare completamente idea sul paese che ci ha ospitati.
Già alla partenza vediamo attraverso le finestre del bus una Lima diversa da quella diMiraflores e San Isidro, quartieri centrali, occidentali, la parte più ricca della capitale peruviana. Fuori da Lima incontriamo il deserto. Centinaia di migliaia di speranze sono in coda e aspettano in mezzo al traffico della periferia o si affievoliscono e scompaiono non riuscendo a scappare da una prigione senza confini.
Guardando sulla destra il paesaggio è incredibile: stiamo attraversando un altro pianeta. à come se improvvisamente dal cielo piccoli cubi colorati fossero caduti disponendosi in ordine sparso, senza un senso apparente, su una crosta dura, arida e rocciosa. Il blu, il bianco, il giallo risaltano sul rosso ferroso della sabbia. Le case continuano a perdita dâocchio. Non ci sono strade, fognature, infrastrutture di qualsiasi tipo. Non ci sono terreni coltivati, la terra è arida, qui non câè acqua. Comâè possibile vivere in queste condizioni? Eppure è proprio qui che abita la maggior parte delle tante persone che lasciano le Ande in cerca di nuove possibilità .

Noi facciamo il viaggio inverso: partiamo dalla loro destinazione per andare a vedere con i nostri occhi i motivi che li portano a lasciare le montagne, ad abbandonare le loro radici.
Sulle Ande, più si va in alto più ogni azione, movimento diventano lenti e faticosi, ogni cambiamento è difficile. La sensazione fisica è evidente, una certa pesantezza pervade i nostri corpi. I panorami sono meravigliosi, lâorizzonte visivo si espande, ma lâaria si fa sempre più rarefatta: la montagna a volte soffoca. In tanti decidono di andare via, soprattutto i giovani, perché per chi resta qui i cammini possibili sono pochi, i mestieri si contano sulle dita di una mano: puoi scegliere tra fare il contadino, lâallevatore o tessere, poco altro. Anche per noi, pensiamo, la scelta sarebbe una sola, forzata, vitale: andare via, cercare fortuna altrove.
Il nostro piano iniziale era visitare il progetto finanziato dalla Provincia di Trento sulla coltivazione dellaTara in alta montagna. Il progetto, come ci spiega padre Fabio in un breve incontro a Lima, consiste di tre parti fondamentali: il primo è il settore ambientale, bisogna portare acqua e lavorare i territori incolti, seminare e far crescere gli alberi; poi câè il processo di raffinazione che porta alla separazione dei tre elementi che costituiscono il seme della Tara, da cui vengono ricavati prodotti che è possibile utilizzare nellâindustria cosmetica, per la colorazione del cuoio, come addensante o come mangime per gli animali; ed infine il processo di commercializzazione, che è appena agli inizi.
âSulle Ande â ci dice â è importante trovare del capitale naturale preesistente che possa essere utilizzato e sviluppare alcune capacità dei ragazzi in maniera tale che nel tempo, con le loro mani, imparino a far fronte al problema della sussistenza, al problema economico. Quella delle Ande è una popolazione povera che desidera migliorare la propria condizione e la maniera di lavorare nel territorio. A Chacas, a San Luis stanno facendo delle cose grandi, vedrete con i vostri occhi!â
Appena arrivati a Chacas capiamo che il progetto della Tara è solo un piccolo tassello di un enorme mosaico fatto di realtà piccole e grandi che lâoperazione Mato Grosso porta avanti ormai da più di trentâanni sul territorio andino. Ci sorprendiamo vedendo che elementi costruttivi tipici dei rifugi montani alpini sono stati utilizzati assieme a tecniche e materiali propri della popolazione ospitante. Nascono così chiese e oratori, il santuario di Pumallucaye el Vivero di San Luis, mense per i poveri e centri di accoglienza (come la casa Santa Teresita gestita da Erica), strutture per le persone portatrici di handicap, abitazioni e un ospedale. Ci raccontano che è lâunico ospedale in quel versante delle Ande. Prima della sua costruzione gli ammalati dovevano essere trasportati anche per sei-sette ore di strada sterrata passando la Cordillera a 4900 metri per arrivare al primo ospedale e molto spesso morivano durante il viaggio. Lâospedale adesso serve tutta la zona ed è mantenuto da medici e infermieri volontari. à una struttura pubblica e questo acquista un valore ancora maggiore se si tiene conto che nel resto dei normali ospedali peruviani se non hai una buona assicurazione non hai diritto alle cure, e le spese a volte sono enormi.
Nella casa parrocchiale di Chacas incontriamo madre Flavia che ci racconta un poâ come nasce il progetto: âPadre Ugo è un sacerdote salesiano, fondatore dellâoperazione Mato Grosso, un gruppo giovanile che raggruppa tanti gruppi in Italia ed ha molti volontari in Sud America: in Perù, Brasile, Bolivia e Ecuador. Padre Ugo nel â76 è venuto a Chacas come parroco e, visitando i villaggi circostanti, si è commosso per la povertà della gente vedendo che morivano tanti bambini, tante donne. Ha pensato che celebrare le messe non fosse sufficiente; doveva fare qualcosa di concreto e così, un mattone dopo lâaltro, questa casa ha preso forma. Essa è un poâ il cuore di questa missione, è aperta a tutti, ai poveri, alle persone di passaggio, a tutti quelli che vengono a farsi curare allâospedale: qua facciamo da mangiare per 800 persone tutti i giorni. E non è lâunica, ad oggi in tutto il Perù ci sono 52 missioni.â
In ogni villaggio che abbiamo visitato vivono alcuni nuclei di famiglie italiane che si occupano di gestire i progetti avviati o di crearne di nuovi in collaborazione a volontari peruviani. Dietro ognuno di questi centri, dietro ogni progetto, câè la vita di tante persone, italiane e autoctone. Dietro ogni esperienza creata ci sono le donazioni delle famiglie italiane, ci sono tentativi, ci sono fallimenti e lutti, ci sono i sogni e la fatica di chi ha creduto nella sua realizzazione.
âOgni progetto nasce dalla preoccupazione di offrire ai ragazzi un cammino per la propria vita, nella quale la questione economica è consistente. Quindi non è possibile una formazione umana completa se non câè la volontà di risolvere il loro problema economico, problema che riguarda tutta lâAmerica Latina ed in particolare sulle Andeâ (Padre Fabio).

à proprio per questo motivo che sono nati orti, foreste per la produzione di legno, campi da cui ricavare foraggio per animali, ma soprattutto scuole professionali, cooperative artigianali e laboratori di lavorazione del legno, del vetro e della pietra. I manufatti che vengono creati nei laboratori di artigianato raggiungono livelli di eccellenza; lâalta qualità delle creazioni ha permesso la loro vendita in tutto il Perù e in molti paesi esteri.
âAlle persone che aiutiamo cerchiamo di trasmettere lâidea che ci sia sempre qualcuno più povero, che va a sua volta aiutato. Speriamo con questo di creare un circolo virtuoso di aiuto, non solo diretto ad una piccola porzione di popolazione, evitando di creare unâélite di nuovi ricchiâ, ci spiega Enrico che da 25 anni vive nelle Ande e si occupa di 12 piccoli laboratori artistici del legno a San Luis. Enrico ci ospita, ci apre la sua casa e nello stesso tempo si apre, cercando di raccontarci la sua storia, il suo incontro con la popolazione andina. Viene travolto dalla nostra curiosità , dal fiume di domande che ci attraversa e che riversiamo su di lui. Gli chiediamo del suo arrivo a San Luis, delle difficoltà incontrate, delle motivazioni che spingono una persona nata in Italia a decidere di passare la propria vita in un paesino nel cuore delle Ande, di come le scelte di un padre condizionino e indirizzino la vita dei figli, di come lui viva il suo ruolo di missionario. Una domanda fra le tante, nate spontaneamente, durante una passeggiata, seduti insieme a tavola o durante uno degli spostamenti colpisce nel segno ed apre una discussione: il lavoro dei missionari, così attenti alla carità e allâeducazione e così legati alla religione cristiana, può celare dietro alla proposta di un rinnovamento umano, economico e sociale, una forma silenziosa, magari anche non voluta o comunque sotterranea, di colonizzazione dellâimmaginario, di sottile prevaricazione, portando ad una logica di costante dipendenza della popolazione che si intende aiutare?
Enrico risponde parlandoci della sua personale visione della cooperazione internazionale: âcâè una teoria famosa nellâambito del volontariato ed anche delle missioni che è quella di non regalare il pesce ma di insegnare a pescare. à una teoria a nostro avviso incompleta nel senso che bisogna fare le due cose sempre. Sempre bisogna regalare un pesce a chi ha bisogno e sempre bisogna insegnare a pescare a chi può imparare. Questo perché lasciare questa gente da sola vuol dire abbandonarla di nuovo a una realtà poverissima, a delle distanze enormi, paesaggi stupendi che però quando non hai niente da mangiare, solo quattro patate e un poâ di granturco, il paesaggio non lo vivi più. Per cui per noi è fondamentale il camminare insieme a loro e non il renderli indipendenti: io personalmente quando sento parlare di non creare dipendenza nei nostri confronti mi viene da ridere, mi sembra la scusa per non condividere la vita con queste persone, per dire io sto qua un poco di tempo e dopo me ne torno a casa mia. Coloro che possono spiccare il volo, se tu gli dai tutti gli strumenti necessari, volano. Ognuno è libero: quelli che hanno questo spirito e questo talento giustamente posso evolversi ed è una cosa molto bella, però tutti gli altri, quelli che non hanno questo? [â¦] Noi ci muoviamo su due piedi, quello dellâeducazione e quello della carità : il piede della carità consiste proprio nel farsi carico delle persone più bisognoseâ.
Spesso ci fermiamo a guardare le montagne. Il paesaggio andino lascia senza parole, lâincontro tra lâintenso blu del cielo e la lunga striscia frastagliata, bianca, immensa della Cordillera invita al silenzio, alla meditazione. Siamo a Pukajacu.

Pucajaku, âvuol dire acqua rossa â ci inizia a raccontare padre Giorgio Barbetta (chiamato da tutti Burbis), giovane rettore del seminario di Pumallucayâ perché qui sopra ci sono delle sorgenti dâacqua che contengono ferro. Queste sorgenti sono importantissime perché danno acqua a tutta la valleâ. Qui è stato realizzato il progetto âLatte fonte di vitaâ finanziato dalla Provincia di Trento, sullâallevamento di mucche da latte per la produzione casearia. âFacciamo qualcosa per dare della vita. Ci interessavano soprattutto i ragazzi e i poveri. Sognare qualcosa per loro: un ambiente pulito, un ambiente bello, una vita non costretta nella periferia della città . A Lima vive un terzo della popolazione del Perù. Una gran parte di questi vive in condizioni pessime con il miraggio di una vita migliore. Noi abbiamo pensato di fare qualcosa cogliendo il lato positivo del vivere in montagna, per i ragazzi che vogliono riflettere sulla vita, che vogliono lavorare e sognareâ.
La malga si trova ad unâaltitudine di 3800 metri, quasi in cima alla montagna i cui terreni sono stati acquistati 20 anni fa da Padre Ugo per la riforestazione a pino, con lâobbiettivo di produrre legname per la costruzione. Un pezzo di Trentino sulle Ande che viene raggiunto da una strada anchâessa costruita grazie al contributo della Provincia. âIniziammo un lavoro un poâ pionieristico, fare 10 km di strada, senza avere un progetto finanziato, con solo poche persone che sapevano come si apre una strada. Allâinizio abbiamo incontrato degli ostacoli, ma adesso la comunità locale ha un modo agevole per scendere dalla montagnaâ.
Per chiudere questo breve reportage dellâesperienza passata sulle Ande abbiamo deciso di riportarvi un frammento dellâintervista fatta a padre Burbis che forse racchiude in seâ il senso intimo e insieme collettivo di una scelta, della voglia di vivere e creare in un contesto ancora pregno di una profonda ed antica spiritualità :
âMi piacerebbe aiutare i ragazzi a sognare di poter vivere una vita bella, mi piacerebbe sognare Dio: che si trova più nel silenzio che nel rumore, che si trova più nella fatica che nelle cose comode e che è sempre più difficile da sognare perché non riusciamo più a trovarlo da nessuna parte, a volte neanche più nelle chiese. Quando porto qua i ragazzi a lavorare, nel mio cuore câè la volontà di farli sognare, far loro sognare qualcosa di molto bello e se è molto bello somiglia a Dio. Questo è un posto che piace a chi sa sognareâ.